.
livello elementare
.
ARGOMENTO: STORIA NAVALE
PERIODO: XX SECOLO
AREA: MAR TIRRENO MERIDIONALE
parole chiave: relitto
Abbiamo parlato in un articolo passato del Valfiorita, una motonave che terminò la sua ultima navigazione nei pressi dello Stretto di Messina. Ci è pervenuto un dossier piuttosto interessante che ci racconta con ancora maggiori dettagli la sua storia. Un riferimento in più per chi volesse recarsi su quel relitto. La motonave Valfiorita era stata commissionata ai cantieri Franco Tosi di Taranto nel 1939 dalla Industrie Navali Soc. Anonima – I.N.S.A. di Genova ed approntata presso il Molo 82. La consegna prevista inizialmente per il mese di luglio del 1942 venne rimandata più volte a causa di ritardi accumulati durante la costruzione anche a causa delle difficoltà di reperimento di tutte le attrezzature ed i materiali necessari per il suo completamento. Fu finalmente varata il 5 luglio del 1942 e sottoposta alle prove di navigazione nei giorni seguenti. Fu solo il 17 settembre che la Valfiorita, alle 08:00 del mattino, venne ufficialmente consegnata all’armatore e contestualmente requisita dalla Regia Marina.

La Valfiorita era una moderna nave da trasporto lunga 144,47 e larga 18,65 metri, con un’altezza al ponte principale e al ponte di riparo rispettivamente di 8,98 e 11,85 metri con una stazza lorda di 6.200 tonnellate. La propulsione era assicurata dalla sua grande elica, mossa da un motore Tosi diesel a due tempi ad 8 cilindri da 6700 cavalli che poteva far navigare la nave ad una velocità massima di 14-15 nodi. Essendo in tempo di guerra, ne era stato previsto l’impiego come trasporto merci e truppe per il contingente italiano destinato alla Campagna d’Africa.
La Regia Marina aveva fatto equipaggiare la motonave di un armamento difensivo costituito da un cannone da 120/45 mm e tre mitragliatrici antiaeree da 20 mm. Per rendere inoltre meno facile l’individuazione della nave da parte di navi e aerei nemici era stato installato anche un impianto nebbiogeno a cloridrina che avrebbe dovuto nascondere il trasporto dietro una spessa cortina di fumo.

La Valfiorita in allestimento – Archivio Mauro Millefiorini
Il primo viaggio
Il suo viaggio inaugurale prevedeva, partendo dal porto di Taranto, il trasporto di uomini e mezzi sia italiani che tedeschi fino al porto di Bengasi, città della Libia che all’epoca era colonia italiana. Le procedure di carico della nave erano iniziate il 20 settembre e durarono sette giorni. Grazie al rapporto del capitano di fregata Ernesto Porcari (incaricato della perizia sui danni della motonave) sappiamo che a bordo della Valfiorita vennero stivate 4.171 tonnellate di merci, compresi 77 mezzi italiani, 206 moto italiane, 95 automezzi tedeschi tra cui anche alcune moto, 16 cannoni e 14 vetture. Vennero anche imbarcati 110 soldati italiani (tra cui quattro ufficiali e quattro sottufficiali) e 100 soldati tedeschi compresi due ufficiali e 9 sottufficiali. La partenza da Taranto avvenne il 3 ottobre 1942 alle 15:10 sotto il comando militare del capitano di corvetta Giuseppe Folli, dalle costruzioni in Mar Grande, e la motonave venne presa in custodia dalla scorta costituita dalle tre cacciatorpediniere Pigafetta, nave comando della scorta, Camicia Nera e Saetta. La navigazione fu tranquilla fino a sera poi con il calare del buio iniziarono a farsi sentire gli inglesi: poco prima della mezzanotte fu dato l’allarme aereo e successivamente furono accesi i nebbiogeni di bordo. Poco dopo un aereo a bassissima quota sganciò un siluro colpendo la nave sul lato sinistro verso poppa in corrispondenza della stiva numero 5, provocando un grosso squarcio sull’opera viva dello scafo e procurando immediato allagamento delle stive numero 5 e numero 6 che si estese poi anche alla galleria dell’asse dell’elica. A seguito del siluramento, 31 persone tra cui un ufficiale di bordo, 13 civili e 17 militari, senza alcun ordine del Comandante, si calarono in mare con una scialuppa di salvataggio, che si rovesciò causando la perdita di due civili che furono dati per dispersi. I naufraghi di questo episodio, furono recuperati dal cacciatorpediniere Saetta. Nonostante i danni subiti, la galleggiabilità della nave fu mantenuta e la Valfiorita riuscì a raggiungere Corfù con i propri mezzi la mattina del 4 ottobre. Da Corfù, il 25 novembre, dopo aver eseguito alcune riparazioni sommarie, la motonave potè rientrare a velocità ridotta verso Taranto dove arrivò il giorno successivo, rimanendo in rada fino al 1 dicembre, prima di essere portata in bacino per i necessari lavori di manutenzione in cantiere, lavori che durarono fino alla metà del 1943.
Interessante il rapporto di attacco della RAF:
“ Il 3 ottobre 1942, la motonave Valfiorita di 6000 tonnellate di stazza diretta a Bengasi da Taranto, è stata avvistata fuori da capo Santa Maria di Leuca da uno spitfire da ricognizione a lunga autonomia. La stessa notte, tra il tre e il 4 ottobre, sono stati inviati quattro Wellington del sessantanovesimo squadron di base a Malta, di cui due armati con bombe e due armati con siluri per attaccare il convoglio. Sono state sganciate 4 bombe da 1.000 libbre da 3.500-4.000 piedi che hanno mancato il bersaglio anche se uno dei proiettili è caduto a sole 150 Yard dalla poppa della nave. In un attacco a bassissima quota (110 feet) il Wellington HX605 “L” pilotato dal sottotenente WH Matthews, sganciava il suo siluro da circa 700 Yard colpendo la Valfiorita a poppa; un grosso bagliore rosso è stato visto a mezza nave. L’aereo di Matthews rimaneva colpito dai colpi della contraerea che ne determinarono la perdita al rientro in atterraggio al campo di Luqa per danni gravi al sistema idraulico.“

Sopra e sotto … estratto del rapporto d’attacco della RAF sulla ricognizione dello Spitfire BR 662 e del suo avvistamento del convoglio con il Valfiorita e la descrizione dell’attacco dei Wellington e della perdita all’atteraggio del velivolo colpito dalla contraerea della Valfiorita. National Archives AIR -27-611_1 – AIR 27-607_10

Le mitragliatrici contraeree della Valfiorita
Dal rapporto della RAF si evince che le 3 mitragliatrici 20/70 della Oerlikon furono previste dal progetto originale della costruzione della Valfiorita, ma il 22 settembre del 1942 la Regia Marina italiana richiese, attraverso la Direzione degli Armamenti, il rinforzo delle piazzole antiaeree per poter installare degli affusti quadrinati di mitragliatrici tedesche, le Flakvierling 38 da 20mm (Flak è la forma abbreviata di Fliegerabwehrkanone, cannone antiaereo). Le tre piazzole antiaeree erano collocate all’estrema prua, a mezza nave e sulla tughetta di poppa.

Soldati della Divisione Panzergrenadieren “Großdeutschland si addestrano all’uso di una postazione Flak 38 – Bundesarchiv Bild 183-J08339 – Autore foto Schwahn 5.11.1943 Bundesarchiv Bild 183-J08339, Ausbildung an der Vierlings-Flak.jpg – Wikimedia Commons
L’aggiornamento della contraerea a bordo della nave fu motivato dalla necessità di incrementare la capacità difensiva con una maggiore cadenza di fuoco per 1.800 colpi al minuto, e con una maggiore portata di tiro, fino a 2.200 metri di altezza, utilizzando il munizionamento da 20 x 138mm B (belted case), Long Solothurn prodotto dalla Svizzera Solothurn fin dai primi anni ’30. Tra i militari tedeschi imbarcati sul Valfiorita, si trovavano certamente anche i serventi delle tre postazioni antiaeree. Questo tipo di aggiornamento d’arma fu adottato anche sulla torpediniera classe Ciclone e sulle motosiluranti posamine classe Canguro 74 e 75.
fine parte I – continua
testo e foto forniti dall’autore sulla base della ricerca effettuata
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, pur rispettando la netiquette, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
- autore
- ultimi articoli
vive e lavora a Napoli occupandosi di pianificazione e controllo di gestione aziendale. Ha da sempre dedicato tutto il suo tempo libero al Mare di cui è amante appassionato, alla fotografia ed alla video ripresa amatoriale. Dopo aver visitato numerosi siti al di fuori del Mediterraneo, negli ultimi anni si divide tra il Golfo di Napoli e lo Stretto di Messina del quale si è profondamente innamorato. Ed è proprio nello Stretto che, grazie a Domenico Majolino, ha cominciato il percorso della subacquea tecnica per raccontare con le immagini le sue meraviglie sommerse sempre con maggiore consapevolezza e sicurezza. La partecipazione a progetti di studio, ricerca e documentazione sui relitti sommersi con il team di Ecosfera, rappresenta un ulteriore valore di arricchimento nel praticare questo splendido hobby























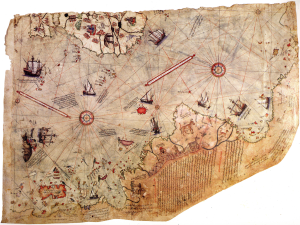








































Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.