.
livello elementare.
ARGOMENTO: STORIA DELLA SUBACQUEA
PERIODO: XX SECOLO
AREA: DIDATTICA
parole chiave: habitat subacquei, Cousteau
Uomini sul fondo
Tutti ricordano quando, nel 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, per la prima volta nella storia dell’Umanità, misero piede sulla Luna. Una grande impresa per la conquista dello spazio che aveva seguito un’altrettanto incredibile sfida incominciata sette anni prima negli abissi. Eravamo nel 1962 quando il ventinovenne Robert Stenuit aveva dimostrato che l’Uomo poteva vivere sott’acqua rimanendo per 24 ore alla profondità di circa 60 metri all’interno di un habitat decisamente spartano, un cilindro metallico lungo 3.3 metri e del diametro di soli 90 centimetri. Questa struttura era stata progettata dal geniale e versatile Edwin Link già noto per aver realizzato il primo simulatore di volo. Era l’inizio del sogno di conquistare le profondità marine e di viverci per prolungati periodi di tempo. La miscela respiratoria impiegata durante la permanenza sul fondo era composta dal 97% di elio e dal 3% di ossigeno. Queste percentuali garantivano assenza di narcosi d’azoto e limitavano la potenziale tossicità di respirare ossigeno ad alte pressioni parziali.

Expérience Précontinent 3 Capo missione André Laban – autore Laurent Cadeau – Permesso Andrè Laban File:Lamaisonsouslamer.jpg – Wikimedia Commons
Un anno dopo, nel 1963, fu il mitico Jacques-Yves Cousteau a cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio habitat sommerso. Nel Mediterraneo, lungo la costa, francese e nelle calde acque del Mar Rosso vengono calati gli habitat della missione PRECONTINENTE programmata in tre fasi. Dopo i primi esperimenti, nella seconda fase, in un’ambientazione degna di un film di fantascienza, un gruppo di “acquanauti” mangia, dorme e lavora per trenta giorni consecutivi alla profondità di 30 metri.
A differenza dello spartano “cilindro di Link” gli acquanauti di PRECONTINENTE II sono ospitati in una struttura con ambienti multipli dalla forma simile ad una stella di mare con tanto di garage per un piccolo sottomarino. Il documentario della spedizione “Il mondo senza sole” vincerà un Oscar nel 1965. L’ultimo atto di PRECONTINENTE vede sei acquanauti vivere per tre settimane a 110 metri di profondità al largo di Cap Ferrat. Durante la permanenza i subacquei riescono anche ad effettuare la simulazione di una manutenzione su un ipotetico pozzo petrolifero sul fondo. E’ la prova definitiva che l’Uomo può lavorare efficacemente sott’acqua.

Sealab II – conservato al Museum of Man in the Sea in Panama City Beach, Florida – autore EbyAbe – Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0) File:PC Beach MOMITS sealab01.jpg – Wikimedia Commons
Sempre negli anni ’60 la Marina Militare Statunitense finanzia il progetto “Man in the sea” con gli habitat “Sealab”. Durante la missione Sealab II ben 15 acquanauti si alterneranno per una permanenza di 45 giorni alla profondità di 60 metri al largo delle coste della California. Sealab purtroppo terminerà bruscamente a seguito della morte di un acquanauta durante le prime fasi di Sealab III, posizionato alla profondità di 186 metri.

Sealab II – Fonte http://www.photolib.noaa.gov/htmls/nur08016.htm – Autore OAR/National Undersea Research Program (NURP); U.S. NavySEALAB II.jpg – Wikimedia Commons
Nel 1969 la Nasa, la Marina Militare Statunitense, il Ministero degli Interni Statunitense e la compagnia “General Electric” crearono una partnership per studiare gli effetti sul comportamento umano della permanenza in ambienti ostili e per sviluppare l’uso delle miscele respiratorie subacquee.
Il progetto “TEKTITE” si articolerà in due fasi con la permanenza sul fondo alla profondità di 13 metri di gruppi di scienziati ospitati in un habitat costituito da due cilindri verticali lunghi circa 5 metri e del diametro di circa tre metri collegati tra loro ancorati sui fondali delle Isole Vergini. In totale cinquanta acquanauti si alterneranno nell’occupare l’habitat.
Durante la prima fase quattro scienziati rimarranno per due mesi sul fondo compiendo ricerche in campo geologico, biologico e biomedico. Nella seconda fase del progetto un gruppo di sole donne, tra cui la famosa ricercatrice Sylvia Earle, viene selezionato per una serie di studi comportamentali. I risultati della ricerca forniranno importanti dati per capire meglio gli effetti dell’isolamento sugli equipaggi di missioni a lunga permanenza come, ad esempio, la stazione spaziale.

Hydrolab sul fondo – autore OAR/National Undersea Research Program (NURP) – Public Domain. NOAA requests they be credited. See http://www.photolib.noaa.gov/about.html#about_imagesFile:HYDROLAB.jpg – Wikimedia Commons
Nel 1968 un nuovo habitat, “Hydro-Lab”, costruito dalla “Perry Oceanographics”, viene deposto alla profondità di circa 40 metri lungo la costa delle Isole Vergini. Costituito da un cilindro orizzontale lungo 5 metri e del diametro di 2,5 metri ospiterà centinaia di ricercatori e acquanauti che si alterneranno negli studi marini durante gli oltre dieci anni di vita del progetto. Nel giugno 1970 sei acquanauti stabiliscono un nuovo record di profondità passando sei giorni in un habitat a 160 metri nelle chiare acque delle isole Hawaii durante il progetto “AEGIR ”, dal nome del dio del mare norvegese.
Dal fondo del mare verso lo spazio
Oggi esiste un solo habitat funzionante usato per scopi scientifici, “AQUARIUS” posato al largo della Florida ed usato dalla NASA come parte dell’addestramento degli astronauti che passano periodi di tre settimane alla profondità di circa 20 metri all’interno di una struttura cilindrica con uno spazio utile di circa 40 metri quadri, paragonabile a quello del modulo abitativo della stazione spaziale internazionale. Tra le attività principali ci sono simulazioni delle “passeggiate spaziali” ed il montaggio di strutture meccaniche sul fondo.
Negli anni una lunga serie di habitat subacquei hanno occupato il fondo dei mari per periodi più o meno lunghi sia per scopi scientifici che per finalità commerciali. Sono stati fatti molti passi dal claustrofobico cilindro di Link ad oggi, tuttavia il sogno di vivere permanentemente sul fondo del mare rimane confinato ai racconti di fantascienza. Forse in futuro le mutate condizioni ambientali, la necessità di trovare nuove risorse energetiche e nuove fonti di cibo, o semplicemente il desiderio di esplorare gli ancora sconosciuti abissi degli oceani stimoleranno nuove installazioni di habitat subacquei permanenti, con la speranza che questo renda l’Umanità più attenta e rispettosa dell’ambiente marino.
Giorgio Caramanna
in anteprima schema del SEALAB III, Fonte U.S. Navy All Hands magazine ottobre 1968 – All photographs published in ALL HANDS are official Department of Defense photographs unless otherwise designated – autore US Navy Drawing of the US Navy SEALAB III 1968.png – Wikimedia Commons
Una sorpresa per te su Amazon Music unlimited Scopri i vantaggi di Amazon Prime
Alcune delle foto presenti in questo blog possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l’autore o rimuoverle, può scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell’articolo
PAGINA PRINCIPALE
- autore
- ultimi articoli
geologo (PhD) ed oceanografo, ha fondato la società di consulenza GeoAqua nel 2015 anche al fine di condividere la sua esperienza di ricercatore e subacqueo scientifico, sensibilizzando l’opinione pubblica sui principali problemi ambientali. In possesso di una notevole esperienza in idrogeologia e geochimica ed oltre quindici anni di esperienza come subacqueo scientifico in una varietà di ambienti ha condotto diverse attività di ricerca ed è sttao delegato del gruppo europeo di immersioni scientifiche. Ha lavorato come ricercatore presso molte istituzioni internazionali operando in ambienti multidisciplinari con diverse università. È autore di più di cinquanta articoli ed è revisore di riviste internazionali. Attualmente lavora negli Stati Uniti collaborando come consulente al Woods Hole Oceanographic Institution. Nel 2018 ha ricevuto il Tridente d’oro dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche subacquee. Non ultimo è main reporter di OCEAN4FUTURE dagli Stati Uniti























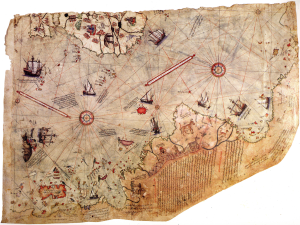








































Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.